Glossario termini
- Adattamento
- Biodiversità
- Cambiamento climatico
- Capacità di adattamento (agli impatti dei cambiamenti climatici)
- Costi d’adattamento
- Disastro
- Effetto serra
- Esposizione
- Evento meteorologico estremo
- Forzante radiativo
- Gestione del rischio di disastri
- Governance climatica
- Hot spot
- Impatti dei cambiamenti climatici
- Indicatori d’impatto
- Incertezza
- Isola di calore urbano
- Macrocategoria
- Misure green
- Misure grey
- Misure soft
- Mitigazione
- Modello climatico
- Pericolosità
- Previsioni climatiche
- Proiezioni climatiche
- Representative Concentration Pathways (RCPs)
- Resilienza
- Riduzione del rischio di disastri
- Rischio
- Rischio di disastri
- Sensibilità
- Scenari climatici
- Scenari di emissione
- Servizi ecosistemici
- Sistema climatico
- Sistema di allerta precoce
- Specie autoctone
- Sviluppo sostenibile
- Variabilità climatica
- Vulnerabilità
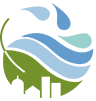
Commenti recenti